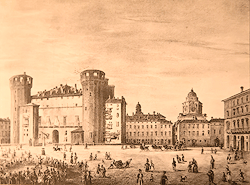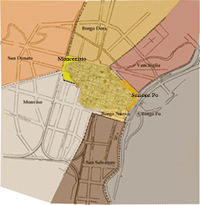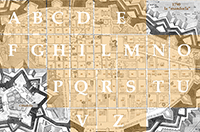Atlante di Torino

LA TORINO NEL 1840
NEI RICORDI DI VITTORIO BERSEZIO - 2° parte
Due scrittori piemontesi, di diversa sensibilità cultura ed eloquenza, vissuti alla distanza di meno d'una generazione, hanno lasciato le proprie memorie con un titolo identico: «I miei tempi ».
Angelo Brofferio le sviluppò in venti volumetti (più tre che seguirono a distanza di tempo, editi a Milano) stampati tra il 1857 e il 1861 in Torino.
Vittorio Bersezio vi si dedicò alla fine della sua vita, per le appendici della Gazzetta del Popolo nel secondo semestre del 1899.
Il suo disegno era di dividere le Memorie in due parti: la prima fino alla ‘fatal Novara’ (1849), battaglia a cui partecipò; la seconda, più politica, da quel cruciale momento alla ripresa risorgimentale.
Una malattia improvvisa interruppe l'opera alla fine della prima parte e l'annunciata ripresa nelle appendici non avvenne mai più.
Noi riportiamo qui il secondo ed il terzo capitolo de «I miei tempi» (Alfredo Formica - 1931, rieditato, illustrato ed aggiornato per i lettori di questo sito). E' la rievocazione che Bersezio fa della città di Torino, delle abitudini dei cittadini, dei rapporti tra le classi sociali, delle condizioni e dei costumi dei vari ceti della città, com'era nel 1840.
2° parte - Aristocrazia - Borghesia - Popolo - Difetti e meriti della prima - Ambizioni della seconda -
Condizioni del ceto infimo - Reciproci rapporti - Differenze - Il vestire - Le passeggiate - A teatro - I servitori - Le villeggiature.
 La popolazione si divideva in tre classi: ceto nobile, ceto medio, ceto infimo, e ciascuna aveva le sue sottoclassi: aristocrazia vecchia e nuova, borghesia grassa e magra, popolo e plebe.
La popolazione si divideva in tre classi: ceto nobile, ceto medio, ceto infimo, e ciascuna aveva le sue sottoclassi: aristocrazia vecchia e nuova, borghesia grassa e magra, popolo e plebe.
L'aristocrazia antica, quasi esclusivamente di origine feudale, aveva resi o rendeva importanti servigi alla monarchia e al paese, col valore in guerra, il talento in diplomazia e nella magistratura, e ne andava giustamente altera, non dissimulando la sua poca stima per gli ordini inferiori, sprezzosa e disdegnosa, forse più che d'ogni altro, della nobiltà nuova.
Sapeva però condire i suoi tratti di una tal gentilezza protettrice che, mentre faceva sentire agli altri la sua inferiorità, ne impediva l'inalberarsi dell'amor proprio. Alcune famiglie - oggi quasi tutte estinte - formavano veramente la parte più colta e studiosa della cittadinanza.
Molti purtroppo si servivano degli agi ereditati, delle supremazie e privilegi sociali e politici solo per arricchire i loro ozi in cortigianesche eleganze; per loro c'erano le prime cariche dello Stato; assicurata la ricchezza con l'eredità di famiglia, perfino difesi dai creditori con decreti del re che obbligavano i creditori a contentarsi solo di una percentuale per un dato numero di anni: prepotenza di fallimento vergognoso per autorità del sovrano.
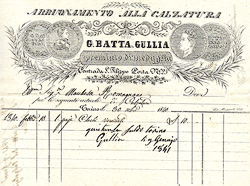 L'aristocrazia nuova era venuta su in parte dalla magistratura, in parte dalla vendita di feudi e di titoli che, sul finire dei due secoli XVII e XVIII, la monarchia aveva ceduto al ribasso per procurarsi danaro nelle pericolose strettezze di quei tempi. Su quella offerta di vanità si era precipitata la ambizione degli arricchiti, e i loro eredi cercavano, quanto meglio potevano, di imitare i comportamenti dei successori degli eroi delle crociate, soprattutto nella prepotenza della superbia.
L'aristocrazia nuova era venuta su in parte dalla magistratura, in parte dalla vendita di feudi e di titoli che, sul finire dei due secoli XVII e XVIII, la monarchia aveva ceduto al ribasso per procurarsi danaro nelle pericolose strettezze di quei tempi. Su quella offerta di vanità si era precipitata la ambizione degli arricchiti, e i loro eredi cercavano, quanto meglio potevano, di imitare i comportamenti dei successori degli eroi delle crociate, soprattutto nella prepotenza della superbia.
L'alta borghesia comprendeva gli arricchiti da poco, i quali, a loro volta, picchiavano alle porte della nobiltà nuova, per essere ammessi a comperare un titolo di barone o di conte. Erano impiegati superiori, o provenivano dall'industria, dalle imprese di costruzione, dal ceto bancario, dal traffico, dall'usura: tutta gente che aveva lavorato, onestamente i più, e poi messo al mondo figliuoli a far nulla gloriandosi nelle penne del pavone; la maggioranza poco saputa e poco curante di sapere. Più intelligente la borghesia media, quella delle professioni liberali: avvocati, medici, ingegneri, professori e maestri, artisti e modesti proprietari rurali indipendenti.
La bassa borghesia comprendeva i piccoli mercanti, i bottegai, smerciatori di derrate, osti, caffettieri, mediatori, e si distingueva per una gran riverenza verso la nobiltà vera e antica.
La plebe (tutti i lavoratori manuali) era rispettosa, non servile, operosa, non scevra di vizi, ossequiente alle autorità, degna di questo popolo, che il Botta chiamò il più ossequiente al suo governo.
 Fra queste classi così diverse, nella vita cittadina, c'era una consuetudine di frequentazione quotidiana.
Fra queste classi così diverse, nella vita cittadina, c'era una consuetudine di frequentazione quotidiana.
Un palazzo torinese era un modello di interazione del corpo sociale. A pian terreno le botteghe e negli ammezzati i bottegai; al piano superiore, che si chiamava superbamente primo piano nobile, l'aristocrazia e la ricchezza; negli altri piani successivi la borghesia sempre minore di grado a seconda che si saliva, e da ultimo, sopra i tetti, nelle soffitte, la plebe.
Questo continuo contatto non era senza utili effetti nei reciproci rapporti.
Non si poteva rimanere affatto estranei gli uni agli altri nelle fasi dell'esistenza. Anche l'aristocratico più superbo, quantunque nella maggior parte dei palazzi salisse al suo appartamento per il solenne scalone a lui solo riserbato, pure sentiva giungere fino alle sue orecchie, e dalle sue orecchie al cuore, la voce del dolore come le espansioni della gioia che venivano dalle sciagure o dalle fortune degli altri abitanti, dal tetto alle cantine; come i suoi patimenti e le sue esultanze trovavano un'eco nei quartieri degli altri inquilini, e se ne commuovevano gli uni e gli altri a vicenda.
Alla moglie del bottegaio che aveva partorito, il piano nobile mandava il brodo ristretto e i confetti e qualche bottiglia di buon vino per le allegrie del battesimo; al capezzale della povera madre, che doleva in pericolo di vita all'ultimo piano, saliva anche la marchesa a recare soccorso di buone parole, di assistenza, all'uopo di denaro; agli orfani dell'operaio ucciso dalla disgrazia sul lavoro, il potente inquilino del piano nobile prometteva e dava la sua efficace protezione; quando il fulmine della disgrazia colpiva l'alto capo del superbo, anche gli umili sentivano la voce della fratellanza che accomuna gli uomini, non fosse che nel dolore; in presenza d'una ricchezza non avara, non sorda alla pietà, la mediocrità borghese, e la stessa povertà plebea, invidiavano certo, ma non maledicevano e non odiavano.
 Era vanto della Torino d'allora che in essa anche le più infime classi avessero nei tratti e nei costumi come una infarinatura di educazione e di buone maniere. Erano la vista, l'esempio delle usanze signorili continuamente sotto gli occhi, da cui i rozzi istinti restavano svergognati; così l'imitazione, qualità essenziale della nostra natura, attingeva norme a cui adeguarsi; onde chi disse male e rise delle nostre soffitte ebbe gran torto. Quella popolazione povera e laboriosa, che allora viveva così frammischiata alla ricca ed agiata, non poteva neanche dirsi plebe; appena in quei tempi meritava tal nome, quella che abitava i pochi e poco frequentati sobborghi; e talmente mancava l'elemento facinoroso e ribelle alle leggi, che quando Torino vide le prime prove dei mascalzoni riottosi, per dar loro un nome, lo prese al dialetto di Milano, dove da tempo era conosciuto e temuto il "barabba".
Era vanto della Torino d'allora che in essa anche le più infime classi avessero nei tratti e nei costumi come una infarinatura di educazione e di buone maniere. Erano la vista, l'esempio delle usanze signorili continuamente sotto gli occhi, da cui i rozzi istinti restavano svergognati; così l'imitazione, qualità essenziale della nostra natura, attingeva norme a cui adeguarsi; onde chi disse male e rise delle nostre soffitte ebbe gran torto. Quella popolazione povera e laboriosa, che allora viveva così frammischiata alla ricca ed agiata, non poteva neanche dirsi plebe; appena in quei tempi meritava tal nome, quella che abitava i pochi e poco frequentati sobborghi; e talmente mancava l'elemento facinoroso e ribelle alle leggi, che quando Torino vide le prime prove dei mascalzoni riottosi, per dar loro un nome, lo prese al dialetto di Milano, dove da tempo era conosciuto e temuto il "barabba".
 Spiccate differenze poi contraddistinguevano i diversi ordini nel vestire, nei convegni, nelle passeggiate, nelle chiese frequentate, nel posto agli spettacoli, nell'arredamento di casa. La magistratura e gli avvocati, i medici, professori e alti impiegati vestivano di nero; gli uomini delle classi agiate con abiti a lunghe falde, a coda nelle occasioni importanti, di panno scuro, talvolta con bottoni dorati, cravatte di seta avvolte doppiamente intorno al collo, alte, dure, colletti dritti che coprivano le mascelle, cappello a cilindro, stivali a mezza gamba sotto i calzoni lunghi, catenella dell'orologio pendente dal taschino con gingilli.
Spiccate differenze poi contraddistinguevano i diversi ordini nel vestire, nei convegni, nelle passeggiate, nelle chiese frequentate, nel posto agli spettacoli, nell'arredamento di casa. La magistratura e gli avvocati, i medici, professori e alti impiegati vestivano di nero; gli uomini delle classi agiate con abiti a lunghe falde, a coda nelle occasioni importanti, di panno scuro, talvolta con bottoni dorati, cravatte di seta avvolte doppiamente intorno al collo, alte, dure, colletti dritti che coprivano le mascelle, cappello a cilindro, stivali a mezza gamba sotto i calzoni lunghi, catenella dell'orologio pendente dal taschino con gingilli.
Ai bottegai e lavoranti la giacca, i colletti rovesciati, scarpe grosse a legacci e berretto. Le donne della piccola borghesia portavano raramente un cappellino, quelle del popolo mai; si ornavano d'una cuffia più o meno elegante; solo le nobili si vestivano di velluto e di raso, si coprivano di pellicce e trascinavano la coda dell'abito sul lucido degli intavolati e sugli scaloni di marmo; la borghese osava qualche volta indossare un cappellino o una mantiglia; la popolana raramente arrivava allo sfarzo d'una veste di seta.
 Per le passeggiate i diversi ceti avevano luoghi diversi o diverse ore nei medesimi luoghi.
Per le passeggiate i diversi ceti avevano luoghi diversi o diverse ore nei medesimi luoghi.
D'inverno solo i portici di piazza Castello e di via Po: ma la gente elegante non oltrepassava la chiesa di san Francesco da Paola. Sull'angolo del caffè Fiorio stavano appostati i damerini aristocratici e i brillanti ufficiali di cavalleria a distribuire complimenti alla bellezza e all'eleganza delle donne.
Lungo la settimana le donne di solito rimanevano in casa e s'occupavano della famiglia.
La sera delIe feste, sotto i portici, v'era una fitta processione di gente, che in due correnti di andata e ritorno si pestava i calcagni gli uni dietro gli altri, colla regolarità di truppe ben disciplinate.
Venuta la primavera, sui viali della Cittadella, dal mezzogiorno al tocco delle feste comparivano le fresche nuove acconciature del sesso gentile che aveva sentito la messa ultima nella chiesa di San Dalmazzo. Erano in generale mogli e figliuole del mondo curiale, avvocati, procuratori e giudici, abitanti nei pressi del Senato (Corte d'appello) e della Prefettura (Tribunale di 1° istanza), che venivano a gareggiare di gusto e di sfarzo, mentre gli studenti e i giovani professionisti ammiravano.
Al tocco sparivano tutti per andare a pranzo, perché allora si pranzava a metà giornata e si cenava la sera alle nove. Lo stesso avveniva nel centro della città, dove il ceto signorile s'affollava alla messa di moda nella chiesa di San Lorenzo. Si andava a fare un giro nel giardino Reale, che, cominciando dal mese di maggio fino a tutto agosto, era aperto ogni giorno al pubblico per espresso volere del re. L'affollamento maggiore avveniva nel pomeriggio festivo dalle tre alle cinque, e tale era la ressa per penetrarvi che occorreva pestare i piedi per dieci minuti sotto il portico innanzi al portone. A ogni modo non ci potevano entrare nè le giacche, nè gli abiti laceri e sporchi, nè i cappelli a cencio, nè i berretti, nè le cuffie: sulla soglia due sentinelle con tanto di fucile a baionetta inastata e un individuo grave e serio, vestito di nero, curavano che non ci entrassero se non ortodossi cappelli a tuba, soprabiti da società e cappellini alla moda.
 Dove poi la ricca e nobile società sfoggiava di più le sue eleganze era nel giro delle carrozze dalle quattro alle sei sul viale dei platani, ora corso Vittorio Emanuele II. Le carrozze non erano molte, così che era agevole percorrere il tratto da piazza Carlo Felice al circolo degli ippocastani innanzi al ponte sospeso ( Il «circolo degli ippocastani» era all'incontro di Corso Vittorio Emanuele e di Corso Cairoli, dove oggi c'è il monumento all'Artigliere. lI palazzo all'angolo presenta difatti un'ampia curva, ed anche le aiuole d'accesso al Parco del Valentino risentono del vecchio disegno del circolo, o meglio semicerchio, come risulta dalla bella pianta del Biasioli annessa alla «Descrizioni di Torino» di Davide Bertolotti (ediz. Viglongo)). Anche le carrozze erano eleganti, e le signore che vi stavano adagiate vestivano con quel buon gusto che sempre ebbero le torinesi. Sul bordo dei viali laterali si piantavano file di seggiole dove le buone famiglie borghesi venivano a sedere per ammirare e invidiare, e dietro queste scorrevano lentamente due fiumi di passeggianti pigiati che si compiacevano di quelle mostre della ricchezza concittadina.
Dove poi la ricca e nobile società sfoggiava di più le sue eleganze era nel giro delle carrozze dalle quattro alle sei sul viale dei platani, ora corso Vittorio Emanuele II. Le carrozze non erano molte, così che era agevole percorrere il tratto da piazza Carlo Felice al circolo degli ippocastani innanzi al ponte sospeso ( Il «circolo degli ippocastani» era all'incontro di Corso Vittorio Emanuele e di Corso Cairoli, dove oggi c'è il monumento all'Artigliere. lI palazzo all'angolo presenta difatti un'ampia curva, ed anche le aiuole d'accesso al Parco del Valentino risentono del vecchio disegno del circolo, o meglio semicerchio, come risulta dalla bella pianta del Biasioli annessa alla «Descrizioni di Torino» di Davide Bertolotti (ediz. Viglongo)). Anche le carrozze erano eleganti, e le signore che vi stavano adagiate vestivano con quel buon gusto che sempre ebbero le torinesi. Sul bordo dei viali laterali si piantavano file di seggiole dove le buone famiglie borghesi venivano a sedere per ammirare e invidiare, e dietro queste scorrevano lentamente due fiumi di passeggianti pigiati che si compiacevano di quelle mostre della ricchezza concittadina.
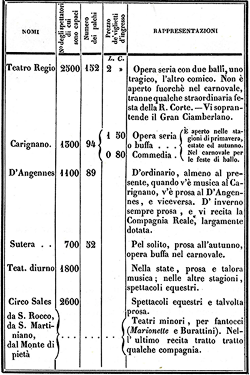 Nei teatri i palchetti erano per i ricchi, i quali, come succede ancora oggi, vi ricevevano i loro conoscenti e ne facevano salotti di conversazione per disturbare gli altri uditori; in platea c'erano i giovani e le famiglie della borghesia minore; il loggione, chiamato satiricamente paradiso, era per il popolo.
Nei teatri i palchetti erano per i ricchi, i quali, come succede ancora oggi, vi ricevevano i loro conoscenti e ne facevano salotti di conversazione per disturbare gli altri uditori; in platea c'erano i giovani e le famiglie della borghesia minore; il loggione, chiamato satiricamente paradiso, era per il popolo.
Al teatro Regio, che chiamavano teatro Grande, i tre primi ordini di logge erano esclusivamente riservati alla nobiltà e alle alte cariche e dignità; nei due ultimi poteva aver posto la borghesia, progredendo dalle logge meno comode e ben situate del quinto, fino alle più centrali del quarto; ma non si otteneva il favore del palchetto se non dopo una lunga e difficoltosa trafila.
Poiché chi allora concedeva e distribuiva i palchetti, stagione per stagione, era l'ufficio del cerimoniere di corte, dove bisognava fare richiesta per ottenerlo quando se ne liberava uno o per rinuncia o per morte o per qualsiasi ragione che ne facesse privare chi l'aveva precedentemente.
Ogni volta che capitava grande era la ressa dei postulanti e, per essere preferiti, necessitavano raccomandazioni, appoggi e compromessi. Nella platea non c'erano sedie chiuse, nè posti riservati e un posticino sulle panche bisognava conquistarselo nelle sere di grande affluenza, colla pazienza di far coda per parecchie ore alla porta prima che si aprisse; non si poteva poi entrare in platea nè nei palchi se non in abito così detto di società.
 L'arredamento di casa nel ceto medio era modestissimo, eccetto per alcuni nuovi arricchiti, i quali ci tenevano ad abbagliare la gente e superare la nobiltà.
L'arredamento di casa nel ceto medio era modestissimo, eccetto per alcuni nuovi arricchiti, i quali ci tenevano ad abbagliare la gente e superare la nobiltà.
I salotti non erano botteghe di minuterie e musei di cianfrusaglie: mobili severi, di forme tranquille, i più in stile impero, stoffe consistenti, specchi pochi e di grandezza discreta, e l'arredo durava anni ed anni. Molte famiglie non avevano il salotto per ricevere e accoglievano gli amici, alla sera, o nella camera coniugale o in quella da pranzo.
Quanto a servitù, la maggior parte delle famiglie si contentava di una fantesca che lavorava molto e si pagava poco, ma che finiva per diventare parte della casa; la padrona non disdegnava talvolta di andare con lei al mercato in piazza del Municipio che allora era detta delle Erbe, ingombra tutte le mattine fino alle dodici dei banchi e delle ceste delle erbivendole, per scegliere le derrate e mercanteggiarne i prezzi. L'avere al servizio un uomo era segno di maggior ricchezza e ambizione.
I nobili e i banchieri milionarii avevano una schiera di servitori fannulloni nelle anticamere, nelle dispense e nelle cucine; pensavano fosse segno ed indizio del loro grado e della loro opulenza; ma nelle case aristocratiche di antica razza un buon servitore non ne usciva più; da vecchio, seguitava a godersi il suo salario senza più prestare alcun servizio; i nuovi arricchiti non avevano di questa signorile considerazione e li cacciavano bravamente sul lastrico, quindi erano serviti con una sprezzante simuIazione di rispetto.
 Giunta l'estate, scoppiavano quella che il Goldoni battezzò le smanie per la villeggiatura. Non c'era ancora la moda delle bagnature al mare o in montagna. I nobili si ritiravano nei loro castelli, i ricchi nelle tenute, i professionisti, i mercanti, i bottegai riparavano nelle ville sulla collina; comprare e possedere una delle quali era il sogno d'ogni buon torinese avvocato, procuratore, notaio, medico e via dicendo; ma non mancavano certi eroi che si tappavano in casa, chiudevano le imposte di legno alle finestre e fingevano assenze almeno almeno di quindici giorni.
Giunta l'estate, scoppiavano quella che il Goldoni battezzò le smanie per la villeggiatura. Non c'era ancora la moda delle bagnature al mare o in montagna. I nobili si ritiravano nei loro castelli, i ricchi nelle tenute, i professionisti, i mercanti, i bottegai riparavano nelle ville sulla collina; comprare e possedere una delle quali era il sogno d'ogni buon torinese avvocato, procuratore, notaio, medico e via dicendo; ma non mancavano certi eroi che si tappavano in casa, chiudevano le imposte di legno alle finestre e fingevano assenze almeno almeno di quindici giorni.
Il popolo, che non aveva castelli, né tenute, né ville, né la melanconia di far credere di averne, prendeva il fresco nelle ore mattutine e serali sotto i magnifici viali della circonferenza, e alle feste si recava in folla a far merenda sul pendio del monte dei Cappuccini, nei prati fuori porta, a giocare alle bocce nelle osterie al di là dei sobborghi.
Vittorio Bersezio
Vedi la I parte:
1 -Torino nel 1840 - Sua area - Alle porte della città - I viali - Modestia -
Semplicità - I caffè - Assenza di monumenti - Piazza San Carlo - Il cavallo di marmo.