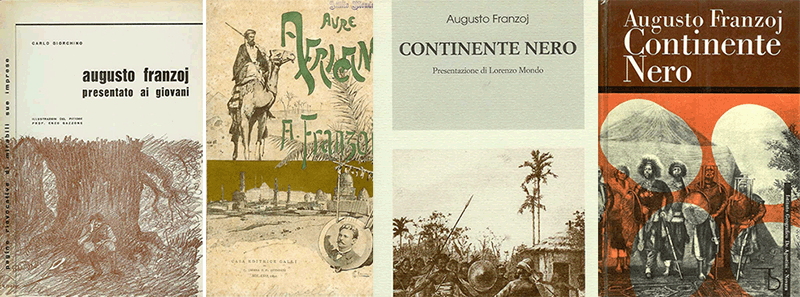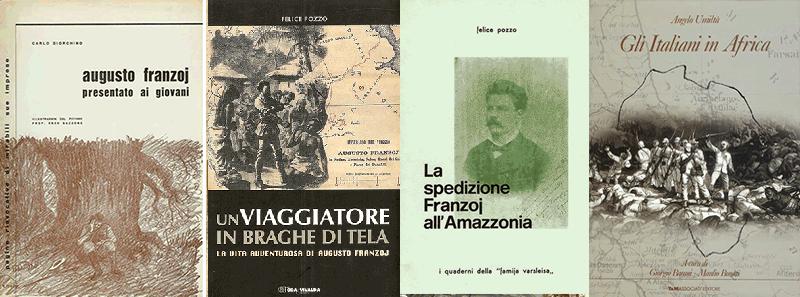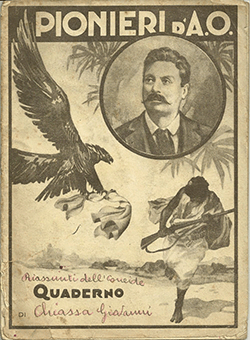 Franzoj come D'Artagnan 5 duelli contemporaneamente
Franzoj come D'Artagnan 5 duelli contemporaneamente
Augusto Franzoj (San Germano Vercellese, 2 ottobre 1848 – San Mauro Torinese, 13 aprile 1911) a 17 anni partì volontario per la Terza Guerra di Indipendenza. Deluso dalle sconfitte di Custoza, Lissa e dall'armistizio, si avvicinò alle idee repubblicane. Così, nel marzo 1870, partecipò alla rivolta di Pavia, ispirata da Mazzini. Essendo ancora in forza all’esercito, come caporale maggiore, fu accusato di alto tradimento e incarcerato a Fenestrelle. Riuscì ad evadere, ma ripreso venne trasferito a Rocca d’Anfo, poi a Gaeta, Verona e Venezia. Esasperato, tentò il suicidio sparandosi un colpo di pistola in pieno petto; rimase solo ferito e l’esercito approfittò del fatto per congedare un elemento così ingestibile e turbolento.
Si stabilì in una povera soffitta a Torino frequentando i giovani scapigliati di quel tempo ai tavoli del Caffè Torino e collaborando saltuariamente con la "La Gazzetta del Popolo”, con frequenti soggiorni in prigione a causa del suo temperamento che lo portava al duello per ogni minima controversia.
Collaborò anche con i giornali rivoluzionari e anti monarchici come La Pulce e il Ficcanaso.
Nel 1872 cinque ufficiali irruppero nella redazione del Ficcanaso malmenando un tipografo.
Franzoj li raggiunse alla birreria Prussia (in via Principe Amedeo angolo via S. Francesco da Paola) e li sfidò a duello tutti e cinque, avendone la meglio. Il fatto fece scalpore e lo costrinse a fuggire in Svizzera, poi in Belgio e in Spagna.
Nel 1882 partì per l'Africa, attratto dai famosi esploratori le cui gesta esaltavano le cronache del tempo. Da solo, senza appoggi né mezzi, riuscì a recuperare i resti dell’esploratore Giovanni Chiarini.
 Franzoj spese in tutto 300 lire per portare a termine questa impresa rischiosa, per la quale l’ambasciatore Pietro Antonelli aveva preventivato per il governo una spesa di 50.000 lire dell'epoca. Dopo aver riportato le spoglie del Chiarini alla famiglia, a Chieti, tornò a Torino ma la sua irrequietezza lo spinse a una seconda spedizione africana passando per Aden, Gibuti e Massaua (dove venne espulso dal comando militare italiano per le sue idee e i comportamenti troppo “libertari”).
Franzoj spese in tutto 300 lire per portare a termine questa impresa rischiosa, per la quale l’ambasciatore Pietro Antonelli aveva preventivato per il governo una spesa di 50.000 lire dell'epoca. Dopo aver riportato le spoglie del Chiarini alla famiglia, a Chieti, tornò a Torino ma la sua irrequietezza lo spinse a una seconda spedizione africana passando per Aden, Gibuti e Massaua (dove venne espulso dal comando militare italiano per le sue idee e i comportamenti troppo “libertari”).
Negli anni successivi tornò più volte in Africa sia come esploratore che come corrispondente, spingendosi poi anche in Sudamerica e nell'America del Nord.
Nel 1908 abbandonò la fede repubblicana, aderendo al socialismo ma senza prenderne la tessera (dichiarò: “Non sono schiavo di nessuno, nemmeno della libertà”) e partecipando alle agitazioni sociali del primo Novecento.
In diversi libri narrò le sue avventure, in Africa conobbe il poeta francese Arthur Rimbaud e a Verona strinse amicizia con Emilio Salgari.
Sposatosi con Ermelinda Angelucci, di vent’anni più giovane, ebbe un figlio, Augusto, e si ritirò a San Mauro Torinese. Tormentato dai dolori di un'artrite deformante, morì suicida il 13 aprile 1911. Con fredda lucidità appoggiò la canna di due rivoltelle alle tempie sparando contemporaneamente, anticipando così di dodici giorni il gesto estremo dell’amico Emilio Salgari che abitava vicino a lui, al fondo di corso Casale, e che per scrivere i suoi libri si era fortemente ispirato alle gesta di Franzoj.
La città di Torino gli ha intitolato una via nel quartiere Parella.
I suoi libri: